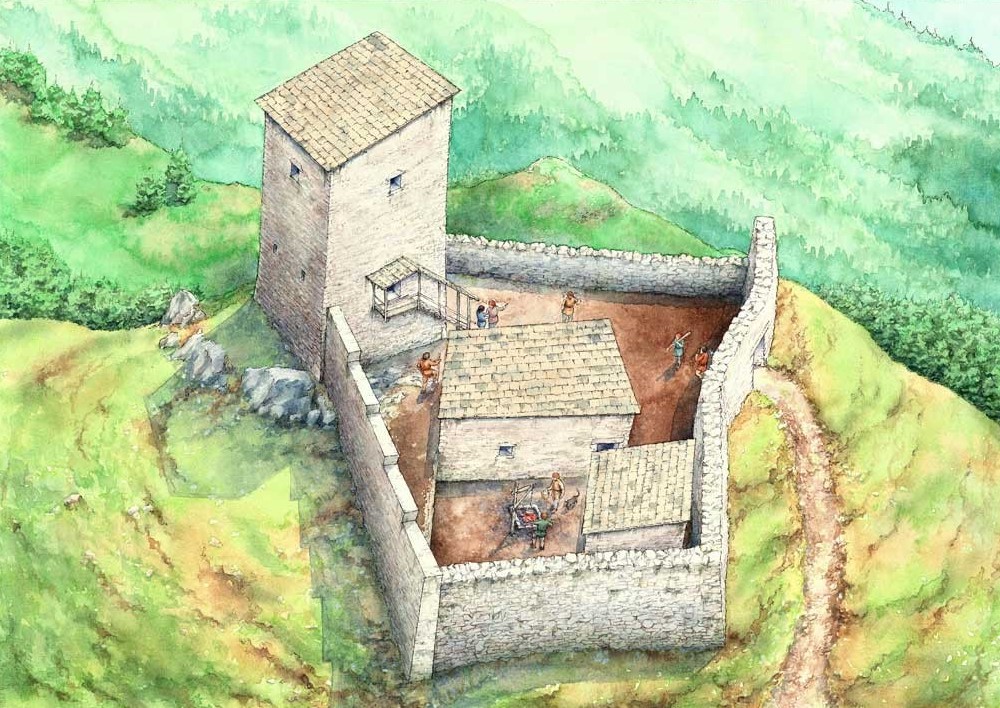L’inevitabile anima lapidea dei nostri paesi ci porta al paesaggio alquanto infernale delle cave, ma anche a quello più gratificante delle candide architetture realizzate con la famosa pietra di Bles: le colonne della chiesa di Vione, il pavimento, le pietre dell’abside romanica, elementi architettonici decorativi, architravi, capitelli, portali, lastre funerarie, lapidi, acquasantiere, balconi. La storia della cava, che si coltiva a 1800 m di altitudine, è storia fatta di sacrifici, di rischi, di fatiche, di tempo per giungere lassù a piedi; storie che solo uomini temprati e disposti ad ogni sforzo ha voluto e ha continuato. Montagna importante la nostra per il materiale che dà, in tutto simile al Candoglia del Duomo di Milano che si presta ad ogni tipo di lavorazione. Il “christall” è un marmo di insuperabile candore: bianco puro, bianco sfumato, bianco venato; l’eccezionale compattezza e durezza si stacca nettamente dai normali marmi bianchi per la particolare cristallizzazione e per la peculiare bellezza del fondo. Più conosciuto e usato nell’antichità, nel Medioevo e nel periodo veneto, la vera storia dell’escavazione inizia nel 1899 quando la ditta F.lli Gregorini ottiene la concessione di una zona della Val di Canè per praticarvi degli scavi allo scopo di ricavare materiali. Nel 1906 la “Società Marmifera Camuna” chiede una concessione per cavare marmo bianco. E’ del 1914 il primo sfruttamento a carattere industriale, anche se di modeste proporzioni, che attua la “Società Marmifera nord Brescia” con sede in Milano fondata dai F.lli Bogani e dal prof. Timo Bortolotti (scultore e autore del Cristo Risorto dell’ossario del Tonale e del Cristo Re di Bienno). Il materiale viene prelevato alla superficie della roccia marmorea senza scavare in profondità. Negli anni venti subentra la “Lithos Marmi” di Virle Treponti che impiega un maggior numero di operai. Furono aperte due cave con perforazioni in profondità mediante gallerie e dal fondo valle i trasporti a Gavero vennero fatti con carri trainati da più pariglie di cavalli. Nel 1939 estrae marmo la ditta Moncini di Capo di Ponte e nel 1950 la Società Tassara di Breno. Nel 1955 subentra la “Marmitalia” di Nuvolera che ottiene la concessione della cava per venti anni. Vi lavorano una cinquantina di operai, usando mezzi più moderni. Si preparavano gallerie con il sistema dei piani sovrapposti e si ottenevano blocchi anche di tre metri cubi. Fu un periodo di lavoro quanto mai redditizio che nel volgere di pochi anni ottenne un buon sviluppo senza raggiungere però una perfetta organizzazione ed uno sfruttamento totale di tale ricchezza. Il nostro marmo era un prodotto affermato su tutti i mercati e la fatica della cava una fonte di benessere per le nostre popolazioni. Nei primi tempi l’estrazione dei blocchi di marmo era effettuata perforando la roccia, inserendovi dei cunei di legno imbevuti d’acqua e battuti con la mazza: l’acqua gonfiando il legno causava il distacco del blocco. Successivamente i cunei di legno furono sostituiti con quelli di ferro sempre battuti con la mazza. Per ottenere più materiale in meno tempo si attuavano “le varate”. Battendo con la mazza la barra da mina, una lunga asta di ferro e acciaio temprato alle due estremità, delle quali una forgiata a scalpello, si producevano diversi fori. In ognuno di deponevano le cariche esplosive e l’innesco avveniva a miccia.

Dopo aver staccato i blocchi dalla montagna, per la squadratura si usava il filo elicoidale. Due fili di acciaio avvolti a elica di 6-8 mm con la lunghezza anche di mille metri, si muovono in circolo chiuso su carrucole che lo guidano premendolo sulla pietra. Una puleggia mossa da un motore gli imprimeva un movimento di traslazione e allo stesso tempo, l’attrito gli conferisce un movimento rotatorio che facilitava il trasporto della miscela di acqua e sabbia con cui era irrorato di continuo. La lavorazione di riquadro e di rifinitura era fatta a mano nel piazzale della cava dagli scalpellini per dare al blocco la forma di parallelepipedo. Il “picapreda” lo si riconosce dalle mani che sono un amalgama di muscoli e di ferro. Dita informi di pelle indurita che hanno impugnato quelle punte di nero metallo che il fabbro aguzzava con la brace. Mani ruvide che hanno stretto il manico del mazzuolo, l’hanno scavato intorno ai nodi, l’hanno lustrato, hanno fatto volare scaglie che erano di troppo. E’ dalle pupille che si identifica l’uomo che ha montato macigni di marmo, che li ha squadrati col mazzuolo e lo scalpello. I suoi occhi, in un volto screpolato dalle rughe, sono ustionati dalle scaglie. Ha usato con maestria i “punciöcc” spinti nella “seda” e i “cügn” di ferro che entravano sicuri per confezionare bianchi parallelepipedi . La montagna, questa nostra montagna non è solo natura, ma un’immensa riserva di esperienze vitali, dove nulla è andato perduto.
Quando i blocchi erano pronti, dal piazzale della cava si dovevano predisporre alle banchine di carico usando la “lizza”. Su robuste travi, leggermente ricurve, spalmate di sapone sulla faccia inferiore, viene posto il masso che si fa scorrere, frenato da cavi di acciaio, su travicelli di legno duro che man mano che il blocco avanza, si levano dalla coda e si posano davanti sotto la “lizza”.
Una rudimentale gru li alzava sul pianale di un camion senza sponde che lentamente scendeva dalla mulattiera della valle per immettersi nella stretta strada comunale ancora dal fondo sterrato. Permettete ora un ricordo per il coraggioso Martino che con uno sgangherato autocarro, mancante di portiere, ha trasportato dalla cava al piazzale di Tagna, confinante con la strada nazionale, tonnellate e tonnellate di bianco e prezioso materiale. La cava chiude nel 1964. Si disse per necessità di ristrutturazione avendo estratto marmo non sempre razionalmente, per la pericolosità della cava, per la difficoltà del trasporto. Da quel giorno molti operai hanno dovuto imparare la vita dell’emigrante.
Dino Marino Tognali